Nel corso degli ultimi mesi, in Italia si è riacceso il dibattito sul tema del fine vita. Per approfondire il discorso su eutanasia, suicidio assistito e testamento biologico abbiamo intervistato il Professor Stefano Canestrari.
Intervista di Alice Spiga, direttrice SO.CREM Bologna, a Stefano Canestrari, professore ordinario di Diritto Penale alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica.
Nel corso di questa estate, quando quasi ogni giorno comparivano notizie e articoli sul tema dell’eutanasia e del suicidio assistito, ho deciso di leggere un libro pubblicato nel 2015: Principi di biodiritto penale.
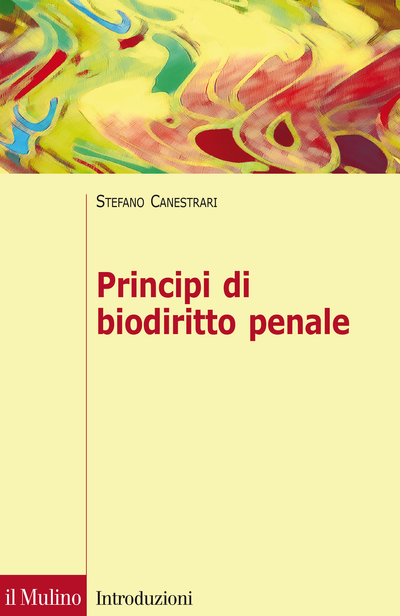
Il volume mi ha da subito colpito perché l’autore, il professor Stefano Canestrari, è riuscito ad affrontare le questioni cruciali connesse alla tutela dell’inizio e della fine della vita umana con una tale chiarezza e semplicità da rendere questa materia accessibile e comprensibile anche a chi, come me, non ha competenze in materia giuridica.
Nel suo libro, il Prof. Canestrari affronta i fondamenti del biodiritto penale, il biodiritto penale dell’inizio e della fine della vita umana, entrando nel merito della liceità del suicidio, dell’intangibilità del corpo umano, del diritto di vivere tutte le fasi della vita umana senza subire trattamenti sanitari contro la propria volontà, di eutanasia e suicidio assistito.
Per approfondire l’argomento, e anche per far conoscere questo libro che, per me, ha rappresentato un porto sicuro nella confusione di termini, significati e contenuti creata dalla miriade di articoli pubblicati (e a questo proposito, si consiglia anche la lettura dell’articolo di Maria Teresa Busca), ho deciso di contattare il Professor Stefano Canestrari, che è stato così gentile da concederci un’intervista.
Professor Canestrari, come specifica nel suo libro, nel dibattito sul fine vita in Italia esiste un’antitesi tra i modelli generali della “indisponibilità della vita umana”, basati sull’assunto che la vita umana è un bene inviolabile e come tale indisponibile, e della “disponibilità della vita umana” (ciascun essere umano è sovrano del proprio essere e quindi ha il diritto di disporne come meglio ritiene). Esistono vie alternative che si possono tentare per uscire da questa dicotomia?
«Sì, credo sia possibile uscire da questa impasse, ma è anzitutto necessario contestualizzare il discorso nell’ambito del diritto penale, che costituisce il terreno fondamentale nel quale si muovono le riflessioni contenute nel mio libro. In pratica, per trattare di questo tema in ottica penalistica, occorre muovere da un’osservazione: quella della sensibile discrasia tra il Codice penale e la Carta costituzionale; discrasia che si riverbera anche sul tema della vita.
«Se, infatti, il Codice penale rispondeva all’ideologia del legislatore fascista, la Carta costituzionale si informa ad ideali liberali: questo disallineamento coinvolge, appunto, anche le tematiche inerenti la persona e, quindi, la vita umana.
«Nel Codice del 1930, tuttora vigente, la persona non acquista un ruolo centrale, essendo invece presa per lo più in considerazione in quanto funzionale al perseguimento di finalità pubbliche. L’assetto valoriale intessuto dalla Costituzione impone, invece, una radicale revisione di questo schema: la persona assume un valore imprescindibile e l’interesse pubblico può emergere, ma solo in un contesto nel quale sia l’individuo stesso ad emergere come “fine”, kantianamente inteso, e non come “strumento” della tutela.
«Assunto questo, occorre poi tenere ovviamente in considerazione le varie declinazioni che la vita può assumere nelle diverse opzioni politico-criminali in campo.
«Se volessimo riferirci ad un caso paradigmatico, potremmo richiamare l’esempio del suicidio. In primo luogo, per le ragioni sopra esposte, oggi non è possibile accreditare quelle impostazioni che ne sottendevano l’illiceità, proprio accordando un valore alla vita umana solo in quanto preordinata alla soddisfazione di interessi pubblici.
«In secondo luogo, debbono ritenersi superate le tesi che ne propugnavano la natura radicalmente contra ius. Piuttosto, sulla base dell’attuale considerazione e della corrente lettura del bene “vita”, possiamo dire che oggi il suicidio rappresenti un atto lecito e libero; altro discorso è, però, se lo si possa considerare un diritto. C’è chi avalla questa impostazione; c’è chi, come me, la respinge, ma entrambe queste prese di posizione poggiano su argomentazioni variamente connotate.»
Un aspetto direi centrale, che lei tiene a sottolineare in diversi punti del suo libro, è l’importanza del dialogo tra realtà diverse che possa, come lei scrive: “allargare quantomeno gli orizzonti, in un confronto tra sensibilità diverse, attente a riconoscere le ragioni degli altri”. Quanto è importante, nel discorso sull’eutanasia e sul suicidio assistito, che si riesca a costruire questo dialogo?
«È fondamentale. Non è mia intenzione sostenere una visione “nichilista” del bene giuridico: il legislatore, quando compie le scelte di incriminazione, non può eludere il confronto con le scienze empiriche di riferimento.
«In materia di eutanasia e di suicidio assistito la riflessione giuridica, e penalistica in particolare, si deve accompagnare ai suggerimenti provenienti da altre branche del sapere: per confrontarvisi, per aprirsi agli input che da questo dialogo possono derivare e, se del caso, per correggere la rotta.
«Il penalista deve insomma essere capace di uscire dalla turris eburnea nella quale tradizionalmente tende a rinchiudersi, per entrare in dialogo approfondito con competenze di matrice extragiuridica.
«Non solo, però: per utilizzare un’immagine che ho varie volte proposto, questo confronto deve avvenire spogliandosi anche della tendenza del giurista a concepirsi come “capocordata”; si è tutti impegnati in una scalata difficoltosa, che richiede una intensa cooperazione. È proprio secondo questo spirito che in Principi di biodiritto penale ho voluto delineare alcuni punti fermi: non perché rappresentino paletti inamovibili dal punto di vista mio o di una specifica categoria, ma perché credo di avervi individuato – in virtù della partecipazione a vari Comitati etici ed al Comitato Nazionale per la Bioetica – elementi condivisi su cui innestare un dialogo proficuo.»
Cito dal suo libro: “Il diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari fa parte dei diritti inviolabili della persona, di cui all’art. 2 Cost., e rappresenta l’applicazione, in ambito sanitario, del generale diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.)”; fatta salva questa premessa, perché l’Italia è ancora tanto restia a legiferare in materia di testamento biologico?
«Le cause sono molteplici. La sua domanda richiede di volgere lo sguardo anche alle opzioni culturali di fondo: e, osservandole, bisogna prendere atto di una diversità di opinioni talvolta piuttosto marcata.
«Parlando del suicidio, ho accennato al fatto che alcuni ritengono vi si debba riconoscere un vero e proprio diritto, altri ne hanno negato la liceità, altri ancora – tra cui il sottoscritto – ritengono che si tratti di un atto libero e lecito, ma non cristallizzato in un diritto. Ebbene, uno schema simile, composto di istanze antitetiche e di possibili punti di equilibrio, si trova anche nel dibattito sul testamento biologico, o, meglio, sulle disposizioni anticipate di trattamento: che però va inquadrato – a mio avviso – in un ambito molto diverso.
«Nel 2008 ho avuto modo di coordinare un parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sul rifiuto e sulla rinuncia ai trattamenti sanitari salvavita. In quell’occasione non volli impostare la discussione sulla base dell’interrogativo circa la possibilità di vedere nella vita un bene disponibile o meno: la questione, infatti, s’inserisce più coerentemente nell’alveo del tema dell’inviolabilità della propria sfera corporea. La base è da riconoscere, oltre che nell’articolo 2 e nell’art. 13, anche nell’articolo 32, secondo comma, della Costituzione: ne discende il riconoscimento di un pieno diritto al rifiuto delle cure o alla rinuncia ad un presidio sanitario.
«Certo, è necessario che il medico dialoghi con il paziente; non è opportuno che proponga la cura o il presidio e prenda meramente atto, sic et simpliciter, dell’eventuale rifiuto: sarebbe una situazione, questa, avvicinabile ad un abbandono terapeutico. Però, se all’esito di un dialogo corretto e rispettoso, il paziente rifiuta la cura o rinuncia al presidio, la sua volontà deve essere rispettata.
«Appare allora evidente come si tratti di una questione profondamente radicata nel rapporto tra medico e paziente. Nell’ipotesi in cui il paziente si trovi in stato d’incoscienza è di fondamentale importanza lo strumento delle disposizioni anticipate di trattamento.
«Su iniziativa di Paolo Zatti, in molti (tra i quali il sottoscritto) abbiamo preso posizione su questo tema, elaborando nel 2012 una Prova di testo normativo. Tale articolato riprendeva, sullo sfondo, la legge approvata in Germania, proponendo che le disposizioni debbano essere vincolanti, ma attualizzate attraverso un fiduciario che si confronti col sanitario; nel caso di contrasto tra costoro, si interpellano i familiari o i consulenti della struttura e, quando ancora non sia possibile comporre le diverse posizioni, il giudice.
«Questa è però una delle posizioni in campo: come dicevo, il ventaglio delle proposte è più ampio e oscilla tra estremi difficilmente armonizzabili. Questo, naturalmente, è il principale ostacolo oggi frapposto ad una condivisa regolamentazione delle disposizioni anticipate di trattamento».
